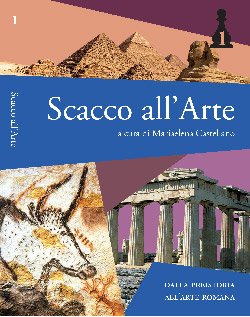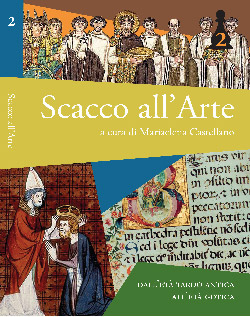Nell’ambito plastico, gli artisti del secondo Novecento, desiderosi di reinventare il loro ruolo, provano a intraprendere nuovi percorsi, in bilico tra astrattismo e naturalismo, sospesi tra tecniche tradizionali e assemblaggi inediti. Venuta man mano meno la sua secolare funzione monumentale e celebrativa, la scultura si esprime adesso attraverso un variegato mosaico di tendenze facenti capo a un vasto repertorio di stili e tecniche. Tra le voci internazionali più autorevoli spiccano le personalità di scultori quali Henry Moore, Alberto Giacometti e Arnaldo Pomodoro.
Lo svizzero Alberto Giacometti (1901-1966) approda a Parigi nel 1922. Qui avviene la sua formazione scultorea, alimentata dall’adesione alle suggestioni cubiste e, in seguito, a quelle surrealiste.

Il suo interesse converge poi sulla figura umana, per la quale mette a punto uno stile del tutto personale dove mira a cogliere una visione d’insieme attraverso un’esile plasticità, evocatrice dei bronzetti preistorici. Le sue figure paiono dissolversi nella loro friabile matericità, divengono sempre più scarne ed essenziali, private di ogni dettaglio secondario: ad emergere è la solitudine dell’uomo nella vacua e silenziosa immensità dello spazio.
Henry Moore (1898-1986) nasce in Inghilterra, dove negli anni del primo dopoguerra avviene la sua prima formazione artistica. Sin da giovane si interessa di scultura e ammira, in particolare, le opere di Michelangelo e, in generale, del classicismo. Si apre, inoltre, alle suggestioni dell’essenzialità dell’arte primitiva, coniugata al fascino della semplicità delle forme presenti già in natura. Negli anni Trenta si lascia sedurre anche dalle ricerche surrealiste e dalle opere cubiste di Picasso e Braque.

Forte di questi molteplici influssi, l’artista perviene gradualmente a un linguaggio sempre più tendente all’astratto, seppur incentrato sulla figura umana, che resta il fulcro del suo operato. Moore propone un linguaggio giocato sulla morbidezza della forma e su un labile equilibrio tra pieni e vuoti, che nel secondo dopoguerra raggiunge vertici di intensa potenza espressiva con sculture di grandi dimensioni, destinate a essere posizionate all’aperto. Ogni dettaglio è studiato con cura, nonostante le sue opere possano sembrare spontanee e casuali. Esse, inoltre, risultano accuratamente contestualizzate e armonizzate con lo spazio circostante.
Arnaldo Pomodoro nasce nel 1926 in provincia di Rimini, ma dagli anni 50 si trasferisce a Milano, dove entra in contatto con le correnti informali. Ben presto l’artista elabora un proprio linguaggio, prediligendo l’uso dei metalli per realizzare grandi sculture da esterno.

Sceglie di operare su forme geometriche, le cui superfici ben levigate creano effetti di speculari luminescenze, mentre crepe e squarci rivelano intricati ingranaggi. Viene così svelata la parte interna dell’opera e questo ricercato contrasto tra il dentro e il fuori si acuisce nei lavori più recenti del maestro, dove i sofisticati meccanicismi si spingono anche oltre l’involucro esterno: sono i disagi e le inquietudini dell’animo umano a emergere, a uscire fuori dagli anfratti più intimi della propria interiorità.
Per quanto concerne l’architettura di questi decenni, dopo la fase di ricostruzione post-bellica, riprendono le istanze messe in moto nella prima metà del secolo con le esperienze funzionaliste del Razionalismo, rinnovate tramite inedite ricerche e sperimentazioni. I maestri del Movimento moderno restano per diversi anni un punto di riferimento, ma la loro lezione viene aggiornata man mano in base a nuove esigenze, sempre più svincolate dal ruolo egemone della funzionalità dell’edificio. Riprendono così vigore sia gli ornamenti, sia i recuperi di stili del passato, tanto da far parlare di “neoeclettismo”. Queste tendenze si concretizzano soprattutto dalla metà degli anni Settanta, quando si inizia a parlare di architettura postmoderna, con un’accettazione piuttosto ambigua e aperta a molteplici e disparati contributi, tutti accomunati dalla necessità di andare oltre il Modernismo della prima metà del secolo, per superarne i limiti di austera razionalità.
La fine del secondo Millennio è segnata da una pluralità di linguaggi artistici che in ambito architettonico spaziano da tendenze minimaliste a scelte decostruttiviste, da citazioni classiciste a esperienze “brutaliste”.
Se sulla scia del Razionalismo, l’architettura minimalista affermatasi negli anni Sessanta, predilige linee nette e semplici, puntando a una purezza formale e all’estrema funzionalità degli spazi, le tendenze del Decostruttivismo scompongono l’edificio in volumi, per poi riassemblarli in modo apparentemente illogico, come in una sorta di caotico collage che utilizza i materiali più disparati e preferisce i giochi dinamici delle linee oblique.
Per Brutalismo si intende invece uno stile architettonico fondato sulla funzionalità e non sull’estetica, privilegiando forme imponenti e massicce e materiali grezzi, in particolare il cemento a vista. Il nome Brutalismo, infatti, deriva dall’espressione béton brut, ovvero “cemento a vista”.
Questa corrente si impone già a partire dagli anni Cinquanta e riscuote successo per il suo linguaggio semplice e aggregante, di chiara comprensione per le masse e propenso alla modernità. Diffusa a livello internazionale, essa assume valori e significati diversi a seconda delle realtà territoriali in cui si opera.
Negli ultimi anni del Novecento, tuttavia, gli edifici brutalisti vengono sempre più inquadrati come esempio di freddezza e trascuratezza, con opinioni sempre più critiche e negative. Di recente, una nuova inversione di tendenza sta però rivalutando questo linguaggio, grazie anche all’azione divulgativa capillare dei social, in particolare di Instagram, dove sempre più post con l’hashtag #sosbrutalism mirano a sensibilizzare il pubblico per salvare queste opere dal degrado in cui spesso riversano a causa della trascuratezza degli ultimi decenni.
Inoltre, negli ultimi decenni del Novecento ci si apre sempre più alle ultime tecnologie e ai nuovi materiali, come si evince in particolare nell’ambito delle tensostrutture, ovvero strutture con coperture fisse sostenute da tiranti e tralicci di acciaio fissati al suolo, che richiamano all’immaginario delle grandi tende.

La fiducia nel progresso scientifico e tecnologico apre la via anche a nuove riflessioni più avveniristiche, spesso ancorate alla sola fase progettuale, ma comunque fondamentali nell’indicare l’esigenza di un cambiamento innovativo, ben evidente poi nel filone dell’architettura High Tech, emersa sin dagli anni Settanta e declinata in diverse varianti fino ai giorni nostri. Un edificio high tech tende a rivelare esternamente tutti i materiali e le strutture di sostegno prima rimasti nascosti, come a voler comunicare al pubblico un messaggio legato anche alla modernità dell’opera.
Tra le numerose personalità di rilievo di questo variegato e complesso panorama architettonico che segna gli ultimi decenni del Novecento fino ad approdare al contemporaneo, emergono le voci note di Louis Kahn, Robert Venturi, Kenzo Tange, Renzo Piano e Frank Owen Gehry.
L’americano Louis Kahn (1901-1974), la cui opera mira al monumentale e si fonda su un uso sapiente dei materiali e della simmetria, come sull’indiscusso valore della luce naturale. Egli si svincola man mano dal principio razionalista della funzionalità per recuperare piuttosto la semplicità del classicismo attraverso la priorità della forma, destinata a caratterizzare l’intensità espressiva della struttura. Il suo linguaggio è talmente singolare, da non risultare inseribile in una determinata corrente del tempo.

Tra i suoi lavori si menziona il noto Edificio dell’Assemblea Nazionale, realizzato tra il 1962 e il 1973, a Dacca, capitale del Bangladesh.
Allievo di Kahn, Robert Venturi (1925-2018) prende sempre più la distanza dall’architettura razionalista, accusata di intellettualismo e di freddezza asettica, nonché ritenuta priva di una valenza emotiva.

R. Venturi, Casa di Vanna Venturi
A partire dagli anni ‘60, Venturi si pone dunque come uno dei principali esponenti del Postmoderno, a cui fornisce anche un contributo critico con i suoi saggi. Tra le sue opere si ricordano Casa di Vanna Venturi (1962), presso Filadelfia, il Padiglione Gordon Wu (1983) per l’Università di Princeton, in New Jersey e l’ampliamento della National Gallery di Londra, realizzato nel 1990.
Considerato il padre dell’architettura orientale contemporanea, il giapponese Kenzo Tange (1913-2005) si pone tra i grandi protagonisti del rinnovamento architettonico tra il secondo Dopoguerra e i primi anni del terzo millennio. Egli parte dagli spunti razionalisti ricavati in particolare dall’incontro con Le Corbusier, per poi aprirsi anche alle vocazioni tradizionali nipponiche, nonché all’utilizzo delle nuove tecnologie, nella costante ricerca di un suo originale percorso, inseribile in una direzione postmoderna.

Tra la pluralità delle opere realizzate da Tange in svariati paesi, emerge lo Stadio Olimpico di Tokyo (1964), progettato insieme agli altri impianti sportivi realizzati in occasione dei giochi olimpici.
Vincitore del Pritzker Architecture Prize nel 1998 e della medaglia d’ora AIA nel 2008, l’italiano Renzo Piano (1937) è una delle personalità più geniali e creative dell’architettura contemporanea.
Tra i suoi tratti fondanti si ricordano le esigenze di luminosità e trasparenza, la propensione a una studiata funzionalità degli spazi e, soprattutto, la straordinaria sensibilità verso un’armonica integrazione dell’opera nell’ambiente. L’inserimento della struttura nel contesto è pensato anche in base ai valori antropologici e culturali di quel determinato luogo, secondo un principio di completamento particolarmente evidente in uno dei suoi lavori più noti: il Centro culturale Jean Marie Tjibaou, realizzato tra il 1991 e il 1993 nell’isola di Nuova Caledonia, in Oceania.

L’opera non consiste in un unico edificio monumentale, ma in una serie di volumi a sezione circolare inseriti nel verde, come le capanne di un antico villaggio kanak, una delle civiltà aborigene del Pacifico. Le antiche abitazioni oceaniche sono infatti richiamate da queste strutture curve ricoperte da centine e listelli in legno, capaci di generare una visione dinamica e avveniristica, seppur fondata sulla tradizione delle costruzioni locali.
Tra le altre numerose opere di Piano va ricordato anche il noto Centre Georges Pompidou di Parigi (1971-77), progettato con l’inglese Richard Rogers (1936), uno dei primi significativi esempi di architettura High Tech. Situato nel cuore della città, il Centre Pompidou si impone come un gran corpo di fabbrica in vetro e acciaio, fiero di rivelare i suoi meccanismi costruttivi.

Non vi è alcun intento di confondere l’edificio nel tessuto urbano, piuttosto si preferisce farlo emergere appieno nella sua vasta mole, per dichiarare a gran voce la sua identità di centro propulsore di cultura, di energica officina al servizio della città.
Tra le altre opere principali di Renzo Piano ricordiamo anche lo Stadio comunale di Bari (1987-1990), l’Auditorium-Parco della Musica a Roma (1994-2004), The Shard a Londra, un colossale edificio ultimato nel 2012, adibito a funzioni commerciali e residenziali, il Museo di Arte Moderna a Oslo (2007-12). il Museo delle Scienze di Trento, inaugurato nel 2013 (nell’immagine di copertina) e, infine, la Biosfera e il Ponte San Giorgio realizzati nella sua città natale, Genova.
Considerato uno dei massimi rappresentanti del Decostruttivismo, il canadese naturalizzato statunitense Frank Owen Gehry (1929) s’impone sulla scena mondiale per le sue opere vitali, segnate da un’energica forza dirompente. Dopo una prima fase ancora legata alle esperienze moderniste, negli anni sessanta l’architetto intraprende un percorso singolare in cui punta a disgregare l’unità strutturale avvalendosi di pareti e linee oblique e di un intenso senso plastico, forte di una carica dirompente, dal sapore quasi espressionista.

Si osservi il celebre Museo Guggenheim di Bilbao, in Spagna, realizzato tra il 1991 e il 1997: l’edificio si impone nel tessuto urbano con la sua grande mole frantumata in più volumi interamente ricoperti da lastre di titanio. Le energiche linee curve ora sporgono verso l’esterno, ora ripiegano verso l’interno, in una perenne tensione dinamica avvalorata dai vibranti giochi di luci e ombre. Le superfici metalliche, infatti, riflettono il cielo e gli edifici circostanti, aprendosi a singolari compenetrazioni con le luminescenze atmosferiche.
Tra gli altri lavori di Gehry si ricorda la Fondazione Louis Vuitton, centro culturale e museo d’arte di Parigi, gestita dalla multinazionale LVMH e inaugurata nel 2014. La struttura si presenta come uno straordinario complesso avveniristico, dove una sorta di iceberg è attorniato da dodici vele di vetro, così intrise di spinte vitali, da sembrare gonfiate dal vento.

L’imponente edificio supera i 40 metri di altezza e vanta una superficie di circa 12.000 mq, con vasti spazi ben illuminati, destinati alle esposizioni permanenti e temporanee del museo, ma anche a molte altre attrazioni destinate ad adulti e bambini.
M. Castellano