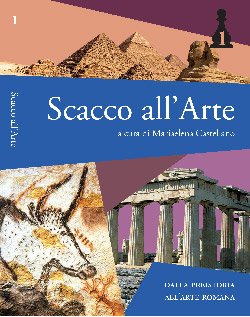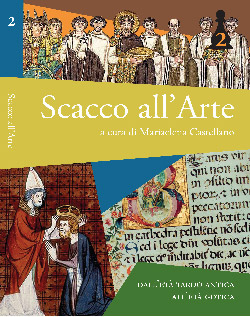Nelle architetture d’Oltralpe, in età gotica, la disponibilità di superfici murarie da poter destinare alle decorazioni pittoriche si riduce sensibilmente, poiché rispetto alle più solide costruzioni romaniche, le mura possenti cedono ora il passo a grandi rosoni e ampie finestre ogivali.
Ciò spiega il declino di affreschi e mosaici, mentre miniature e tempere su tavola, svincolate dal linguaggio architettonico, ricevono un maggiore impulso. Ma è soprattutto la pittura su vetro(*) a caratterizzare l’arte gotica con risultati di grande originalità.
A prescindere dalla tecnica impiegata, la pittura gotica si apre a rappresentazioni più realistiche e dotate di maggiore espressività.
Questa attenzione al vero riflette il contesto storico del tempo: il rafforzamento delle sovranità territoriali, l’ascesa della classe borghese e la diffusione di ordini religiosi che attualizzano il messaggio divino determinano nuove esigenze artistiche. La pittura medievale, così ieratica e simbolica, non può più documentare un’epoca in cui l’uomo acquista più fiducia in sé stesso, aprendosi a una maggiore concretezza.
Nei dipinti, accanto alle iconografie sacre, assumono dunque rilievo soggetti prima ignorati, quali scenari naturali e paesaggi urbani, ma anche rappresentazioni faunistiche o dettagli di vestiari e oggetti della vita quotidiana. Il pensiero medievale di mortificazione della materia in virtù dell’esaltazione dello spirito conosce una battuta d’arresto e pertanto la fisicità dell’uomo, come le sue attività lavorative, acquistano più importanza.
Nella pittura duecentesca e trecentesca, il mondo reale, volutamente messo ai margini dall’arte paleocristiana e ripreso in considerazione da quella romanica, diventa fondamentale e viene espresso attraverso un linguaggio raffinato, dotato di sontuosità decorativa e ricercatezza formale. Linee sinuose e allungate contornano cromie brillanti e dorature lucenti, in linea con il preziosismo ornamentale tipico del gusto gotico.
In Italia, dove l’architettura filtra le innovazioni gotiche per restare ancorata alla tradizione romanica e paleocristiana, le superfici destinate ad aperture e decorazioni a vetro sono limitate, così le pareti possono essere ancora ricoperte da grandi cicli di affreschi e mosaici.
Queste due modalità espressive continuano dunque ad avere una vasta diffusione nel nostro paese, distinguendosi con produzioni di alta qualità e monumentale eleganza. Anche il genere della tempera su tavola conosce un periodo di gran fioritura e divulgazione.
Nella prima metà del Duecento, i raffinati stilemi bizantini, già da secoli ben radicati a Venezia e in Italia meridionale, si irradiano anche nel resto della Penisola, rallentando la penetrazione della nuova sensibilità gotica.
In questa fase, nell’ambito della pittura sacra, affreschi, mosaici e tavole dipinte sono ancora considerati come icone da venerare e dunque risultano permeati da una solenne ieraticità svelata attraverso rigide stilizzazioni formali.
E´ verso la metà del XIII secolo che i pittori iniziano gradualmente a indagare il dato naturale e i moti dell’animo, aprendosi a una rappresentazione più veritiera e attenta all’umanizzazione dei personaggi.
A seconda degli ambiti territoriali, si riscontrano differenti tendenze artistiche, tra le quali emergono quella romana e quella toscana, quest’ultima distinta in due significative esperienze pittoriche: la scuola fiorentina e la scuola senese, che nel Trecento raggiungeranno gran notorietà. Alla base del primato artistico delle due città si pone il ruolo culturale della ricca borghesia urbana, attiva anche nella promozione di importanti dipinti e monumenti.
LA PITTURA ROMANA
Negli ultimi anni del Duecento, le antiche basiliche romane vivono una fase di rinnovo promosso dalla corte papale. Nella città si afferma, pertanto, uno stimolante filone pittorico che rappresenta una fondamentale testimonianza nello scenario artistico italiano di età gotica.
L’originale linguaggio maturato nella Roma di fine Duecento coniuga l’equilibrio e la maestosità di ascendenza tardo antica alla nuova sensibilità lineare e cromatica del gotico, prendendo man mano le distanze dalla tradizione bizantina, comunque ancora ben radicata quanto a suggestioni iconografiche e ad austera rigorosità simbolica.
Ne deriva un’arte monumentale, come si confà al passato culturale dell’Urbe, ma al tempo stesso intrisa da un singolare effetto decorativo.
Tra i nomi di maggior rilievo emergono quelli di Jacopo Torriti e Pietro de’ Cerroni, detto Cavallini, entrambi attivi nella seconda metà del XIII secolo.
Pochi risultano i dati biografici in nostro possesso per poter fare più luce sul loro operato, a oggi interpretato attraverso alcuni importanti lavori realizzati a Roma.
Jacopo Torriti realizza intorno al 1295 il ciclo musivo del catino absidale della Basilica di Santa Maria Maggiore.
L’artista dà qui prova di una consolidata conoscenza della tradizione paleocristiana del mosaico, rinnovata dall’apertura agli stilemi gotici, come attestano le morbide gradazioni cromatiche e l’attenzione alle componenti ornamentali.

La sua abile perizia esecutiva è particolarmente evidente nella spettacolare scena dell’Incoronazione della Vergine, dove una raffinata luminosità perlacea valorizza le delicate tinte degli incarnati.
Un’analoga sensibilità per le modulazioni cromatiche e per un’equilibrata composizione classicheggiante emerge anche dall’operato di Pietro Cavallini.

Nel ciclo di mosaici con Storie della Vergine, realizzato all’incirca nel 1291, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, l’artista rielabora la tecnica musiva, riuscendo a conferirle un verosimile senso di profondità, attraverso la tecnica chiaroscurale e la prospettiva.
La ricerca di una più consistente resa volumetrica si riscontra anche negli affreschi dipinti per la Chiesa di Santa Cecilia in Trastevere intorno al 1293, con Storie dell’Antico e Nuovo Testamento, tra cui spicca la scena della parete della controfacciata con il Giudizio finale.

La procedura dell’affresco, rispetto a quella musiva, offre maggiori possibilità di variazioni cromatiche e più libertà nella stesura delle forme, consentendo così all’artista di mostrare al meglio una vigorosa saldezza plastica e una sapiente impostazione degli spazi.
LA PITTURA FIORENTINA
Uno dei primi segnali del rinnovo della pittura fiorentina del XIII secolo emerge nell’opera di Giunta Capitini da Pisa, noto come Giunta Pisano, di cui risultano poche notizie biografiche.
L’artista si dedica al tema della Crocifissione, privilegiando la versione più umanizzata del Christus patiens. Nelle sue tavole la più composta fissità bizantina viene stemperata dall’accentuazione dei contenuti espressivi, in linea con i dettami religiosi abbracciati dagli ordini mendicanti, in modo da destare un senso di venerata compassione nei fedeli.

Nel Crocifisso conservato nella Chiesa di San Domenico a Bologna, realizzato tra il 1250 e il 1254 circa, il corpo del Salvatore s’inarca in avanti in modo piuttosto innaturale, come a indicare un tentativo di dimenarsi dal martirio, mentre il volto, se pur ancora vincolato a una schematizzazione dei tratti somatici, mostra un’intensa e toccante sofferenza.
Queste innovazioni trovano piena adesione nel fiorentino Coppo di Marcovaldo (1225-1280 circa), attivo in vari centri umbri e toscani. La sua spiccata personalità raggiunge risultati di grande enfasi espressiva nel grottesco scenario del Giudizio Universale realizzato per la decorazione musiva del battistero di Firenze e riferibile agli anni 1260-70.

Anche nella tavola raffigurante la Madonna con Bambino per la Basilica di Santa Maria dei Servi, a Siena, Coppo riesce a infondere una significativa tensione emotiva: il piccolo Gesù, svincolato dalla posizione frontale, tipica degli stilemi bizantini, si volge verso la Madre in un dialogo muto alimentato da un espressivo scambio di sguardi, leggibile ancora oggi, nonostante una successiva ridipintura dei volti.

L’opera si distingue anche per le curate fattezze volumetriche dei corpi, definiti in pose più flessuose. Attraverso un disegno marcato e un sapiente utilizzo della tecnica chiaroscurale, ravvivata da singolari lumeggiature dorate, Coppo di Marcovaldo prende le distanze dai modi pittorici orientali, rappresentando così un importante punto di riferimento per i successivi esiti della pittura fiorentina duecentesca.
Da questi spunti innovativi, infatti, muove i suoi passi Cenni di Pepo, soprannominato Cimabue, considerato il fondatore della scuola pittorica fiorentina.
Nonostante la sua fama, non si hanno molte notizie biografiche; sappiamo che nasce a Firenze intorno al 1240 e che, oltre alla sua città natia, risulta attivo anche a Roma, Assisi e Pisa.
Nella sua formazione alimentata da un filone bizantino colto e raffinato, concorrono anche gli studi delle opere classiche e delle sculture di Arnolfo di Cambio.

In una delle sue prime opere, il Crocifisso della Chiesa di San Domenico ad Arezzo, realizzato tra il 1260 e il 1270, Cimabue riprende la tipologia di Giunta Pisano del Christus patiens, ma esprime un dolore più composto, mentre il vigoroso scatto in avanti del corpo evidenzia l’agonia del martirio.
Se l’accurato uso del chiaroscuro e il disegno nitido proiettano l’artista in un percorso di aggiornamento pittorico, la schematizzazione del ventre e dei lineamenti del volto testimoniano, invece, il suo costante riferimento al linguaggio bizantino, qui espresso con grande eleganza formale.
Nel più tardo Crocifisso realizzato all’incirca tra il 1287 e il 1288 per la Chiesa di Santa Croce a Firenze, Cimabue si distacca maggiormente dai retaggi orientali, conferendo un più accentuato vigore plastico al corpo del Cristo, privato adesso delle rigide partiture muscolari e dotato di una più morbida flessuosità e di una viva forza espressiva.

Nel particolare del perizoma, l’artista si libera dai suoi riferimenti alla tradizione bizantina: la stoffa appare leggera, quasi trasparente, con un richiamo al virtuosistico “effetto bagnato” di età classica.
L’opera ha subito ingenti danni a seguito della violenta alluvione del 1966 ed è attualmente esposta nel Museo dell’Opera di Santa Croce.
Un’altra prova dell’abilità pittorica di Cimabue si rileva nella tavola cuspidata della Maestà(*) realizzata per la chiesa fiorentina di Santa Trìnita e riferibile agli anni 1285-90.
Nel dipinto la scena è dominata dalla studiata articolazione spaziale del grande trono, strutturato come fosse un’architettura: nella parte superiore la Vergine con il Bambino, maestosa, è circondata da due schiere di angeli; in basso, quattro profeti collocati in tre aperture ad arco rivelano un’aura di severa autorevolezza.

La gerarchia dimensionale, il fondo in oro e la trattazione schematica delle forme attestano l’orientamento bizantino ancora presente nell’artista, ma anche in questo caso si possono cogliere importanti segnali di aggiornamento. I corpi, per esempio, appena celati dalle vesti spiegazzate, mostrano una ben definita saldezza volumetrica, mentre i volti si svincolano dalla ieratica fissità delle icone, per esprimere una ritrovata umanità. Si noti, in particolare, la dolcezza del lieve e materno sorriso appena accennato dalla Vergine.
Questa maggiore attenzione ai sentimenti e agli stati d’animo figura anche nel celebre ciclo di affreschi del coro e del transetto della Chiesa Superiore di San Francesco ad Assisi, dove Cimabue è attivo probabilmente tra il 1288 e il 1292 per realizzare, insieme a suoi collaboratori, Storie di Angeli, Storie di Maria e Storie degli Apostoli. I dipinti riversano in uno stato di deterioramento, causato da un processo di ossidazione della biacca, ovvero il composto del piombo usato per ottenere il bianco; pertanto, le parti chiare si sono scurite, mentre le scure si sono scolorite.
Tra le scene più toccanti, menziono la drammatica Crocifissione del transetto sinistro, dove un monumentale Cristo in croce si staglia al centro di una composizione affollata, in cui emerge un’intensa gestualità espressiva.

Le dimensioni gerarchiche e le approssimazioni prospettiche risentono ancora della secolare tradizione pittorica medievale, ma la trattazione volumetrica dei corpi mostra la costante volontà del maestro di rinnovarsi.
L’opera di Cimabue troverà ampio seguito e sul finire del Duecento la sua eredità sarà raccolta e sublimata dal celebre Giotto, per poi confluire nei modi dei pittori fiorentini dei secoli successivi, dando così vita alla cosiddetta “scuola pittorica fiorentina”, un filone artistico votato alla resa spaziale della realtà, da conquistare attraverso il disegno e la tecnica chiaroscurale.
LA PITTURA SENESE
Rispetto agli altri centri della Toscana, Siena presenta un orientamento artistico più aggiornato sugli stilemi gotici d’Oltralpe. La città, infatti, è collocata lungo la via Francigena(*), da dove pervengono influssi culturali francesi. Inoltre, la presenza di Giovanni Pisano, attivo a Siena negli ultimi decenni del XIII secolo, fornisce ulteriori stimoli innovativi improntati agli eleganti modi gotici.
Si sviluppa così un filone pittorico particolarmente sensibile alle innovazioni artistiche del tempo, un linguaggio aulico, dove le forme slanciate e aggraziate si accompagnano ai raffinati preziosismi decorativi e alle intense cromie.
DUCCIO DI BUONINSEGNA (SIENA 1255 circa – 1319)
Iniziatore di questa che viene definita “scuola senese” è Duccio di Buoninsegna, nato intorno al 1255 a Siena, dove risulta principalmente attivo, realizzando opere anche per la vicina Firenze.
Nella formazione di Duccio concorrono molteplici componenti: si va dalla conoscenza della sontuosa produzione gotica francese alla più tradizionale fonte bizantina, dall’apprezzamento delle opere scultoree dei Pisano all’apertura nei confronti della pittura di Cimabue. L’artista si apre a questi variegati influssi, per poi rielaborarli in un linguaggio nutrito da una sua personale propensione all’eleganza decorativa.
La definizione della grafia pittorica duccesca si delinea già nella giovanile Madonna Rucellai, tavola dipinta nel 1285 per una confraternita legata alla Basilica fiorentina di Santa Maria Novella.

Le notevoli dimensioni del dipinto lasciano intuire un’originaria destinazione in prossimità dell’altare, prima della successiva collazione nella cappella Rucellai, da cui prende nome la tavola, oggi conservata nella Galleria degli Uffizi.
La commissione di una grande pala d’altare(*) conferita a un artista senese da un centro religioso di Firenze, città storicamente rivale di Siena, testimonia la fama goduta da Duccio sin dagli esordi della sua carriera.
In quest’opera il maestro oscilla tra le raffinatezze di ascendenza bizantina e il linguaggio costruttivo di Cimabue, mostrando al tempo stesso un gusto per l’eleganza ornamentale di derivazione gotica.
L’esiguo trono su cui è stagliata la Madonna, se pur dotato di giochi obliqui, è privo di valenza strutturale, così come gli angeli, nonostante presentino una più accentuata volumetria, si dispongono uno sull’altro senza alcun intento prospettico.
Ciò che interessa l’artista è piuttosto l’effetto decorativo, a cui concorrono il drappo che copre la spalliera del trono, nonché il sinuoso risvolto dorato del manto della Vergine. Anche la qualità dei colori risponde a questa esigenza ornamentale: le tinte adoperate si esaltano dagli accostamenti reciproci, regalando alla scena un’intensa vivezza cromatica.
Lo sfondo in oro e la gerarchia dimensionale rimandano, invece, agli schemi bizantini di cui è nutrita la prima formazione duccesca.
Qualche anno dopo, l’artista realizza il cartone preparatorio per l’ampia vetrata circolare del Duomo di Siena, dove una grande croce inserita in un tondo determina nove scomparti in cui sono inserite raffigurazioni con i Santi protettori della città, i quattro Evangelisti e tre scene tratte dalla vita della Vergine.

Si tratta di uno degli esempi più antichi e meglio conservati di pittura a vetro gotica italiana, una rilevante testimonianza dell’alta qualità raggiunta in questa tecnica anche nel nostro paese.
L’opera si distingue per la sapiente regia negli accordi lineari e cromatici: gli eleganti giochi formali si rinvigoriscono grazie alla viva brillantezza dei colori e al pittoresco effetto decorativo.
Il Duomo di Siena ospita anche un altro lavoro di Duccio, la celebre Maestà, capolavoro della sua più compiuta maturità artistica, realizzato tra il 1308 e il 1311.
La grande pala è accolta con gran fervore dai senesi e viene collocata sull’altare maggiore del Duomo con una solenne processione devozionale.

Oggi l’opera risulta smembrata e divisa tra vari musei. Lo scomparto principale, conservato nel Museo dell’Opera del Duomo di Siena, nella parte anteriore raffigura la Maestà, mentre in quella tergale presenta riquadri con Storie della Vita di Cristo e di Maria.

Il dipinto mostra la spiccata sensibilità gotica del maestro, palesata nel gusto per un morbido e sinuoso linearismo, e la capacità di recuperare in chiave innovativa l’austera tradizione bizantina, di cui fa rivivere le accese cromie e i maestosi simbolismi.
La Madonna e il Bambino, affiancati da una fitta schiera di angeli e santi, sono dotati ancora di una maggiore dimensione gerarchica; appaiono imponenti e solitari, modellati da un disegno nitido ed elegante, piuttosto che dalla tecnica chiaroscurale. Duccio continua ad anteporre l’esigenza decorativa a quella volumetrica, prediligendo una delicata fusione armonica dei colori e un raffinato equilibrio compositivo delle forme.
Queste scelte stilistiche fanno di Duccio di Buoninsegna il primo illustre pittore italiano di un’aulica corrente goticheggiante. Presso di lui si formeranno altri importanti nomi del panorama artistico senese della prima metà del Trecento, quali Simone Martini e i fratelli Pietro e Ambrogio Lorenzetti.
SIMONE MARTINI (SIENA 1280 circa- AVIGNONE 1344)
Simone Martini spinge gli insegnamenti di Duccio di Buoninsegna in una direzione più spiccatamente gotica e divulga in tutte le regioni italiane i modi raffinati della pittura senese.
Nella Maestà dipinta tra il 1312 e il 1315 su una parete del Palazzo Pubblico di Siena, l’artista mostra la fervida spiritualità della collettività senese, già rivelata qualche anno prima nella Maestà di Duccio. In entrambe le opere, infatti, accanto alla Vergine in gloria, figurano anche i quattro santi patroni della città, venerati con gran devozione.

Nella Maestà di Simone, il rigore geometrico duccesco lascia il posto a una più morbida concezione compositiva, dove angeli e santi, disposti in file, sono definiti in un susseguirsi di forme sinuose, arricchite da luminescenze dorate e intense cromie, in un dinamico e fluido equilibrio compositivo.
Il grande e variopinto baldacchino sovrastante l’affollata schiera di personaggi sacri, così come il trono a schienale cuspidato, concorrono a una resa più tridimensionale della scena. Tali accorgimenti denotano la conoscenza della più realistica pittura fiorentina, in particolare dell’opera di Giotto, ma si tratta di richiami subordinati al prevalente intento decorativo, come rivelano gli ornamenti delle vesti e delle aureole, o i dettagli del trono e della cornice.
La Madonna e il Bambino assumono pose ed espressioni più umane, modellate da una linea raffinata, che concorre alla resa di un’aura diafana ed elegante.
Questi effetti di sofisticata ricercatezza restano una costante del linguaggio di Simone, come si evince anche dagli affreschi con Storie di San Martino, realizzati ad Assisi, per l’omonima cappella della Chiesa Inferiore di San Francesco, all’incirca tra il 1314 e il 1317.

Le scene sono caratterizzate da un vivace gusto narrativo e i personaggi, definiti da colori squillanti e linearismi aggraziati, appaiono come lussuosi cortigiani; gli allestimenti architettonici riflettono la coeva pittura giottesca, ma l’assenza di una salda volumetria allontana il riferimento al celebre pittore fiorentino.
Terminato il ciclo assisiate, Simone Martini è a Napoli, dove intorno al 1317 realizza la tavola con San Ludovico che incorona il fratello Roberto d’Angiò.
L’opera, commissionata dal sovrano angioino, rappresenta un’importante documentazione storica e va inquadrata come uno strumento di propaganda politica, atto a legittimare l’incoronazione del nuovo monarca.

La grande tavola cuspidata è dominata dalla monumentale figura del vescovo di Tolosa, Ludovico, canonizzato proprio nel 1317, per aver abbracciato i voti francescani, rinunciando alla corona partenopea a favore del fratello.
Il santo viene incoronato da due angeli in volo, mentre a sua volta egli incorona Roberto, raffigurato con dimensioni minori, per una chiara allusione alla gerarchia religiosa. Il sovrano, in posa genuflessa e di profilo, come fosse effigiato in un’antica moneta, ha un aspetto regale e volge il suo sguardo austero in alto, verso il fratello assiso in trono, distinto in un’aura severa e distaccata.
La sfarzosa profusione di ori e gli eleganti grafismi donano alla scena una ricercata ricchezza decorativa, ben evidente anche nel celebre Trittico con Annunciazione e santi, dipinto nel 1333 in collaborazione con il cognato Lippo Memmi.
La tavola, ravvivata da intense luminescenze dorate e da raffinati lirismi formali, costituisce un fondamentale punto di arrivo nella carriera dell’artista.
Simone Martini cala il momento sacro dell’annunciazione in un’atmosfera evanescente e umana al tempo stesso.

L’Arcangelo è appena sopraggiunto al cospetto della Vergine, come mostrano le ali spiegate e il mantello ancora svolazzante. La resa decorativa del suo abito, ornato da singolari effetti aurei, è un esempio di altissima qualità esecutiva, nutrita da una sapiente conoscenza dell’arte dell’oreficeria, mostrata più volte da Simone.
La Madonna, intimidita da quest’improvvisa apparizione soprannaturale, si ritrae con un gesto pudico di grande naturalezza: con una mano si porta il mantello al collo e osserva la creatura angelica con un’espressione intimorita.
Ne deriva una scena di gran complessità spirituale, che ben riassume la cifra stilistica del pittore, distinta da una grafia sinuosa e aggraziata.
Le originali cromie della tavola sono riemerse grazie al restauro condotto nel 2002, mentre l’attuale cornice risale agli ultimi anni del XIX secolo, in sostituzione di quella originaria, andata perduta.
Nel 1337, dopo pochi anni dalla realizzazione del trittico, Simone Martini è invitato alla corte papale di Avignone, dove resterà fino alla morte, diffondendo il suo personale gusto goticheggiante in terra francese, con opere purtroppo non pervenute, ma che costituiranno una preziosa fonte d’ispirazione ai successivi prosegui del filone artistico del Gotico Internazionale.
PIETRO (1280-1348) E AMBROGIO (1290 ca. – 1348) LORENZETTI
I fratelli Pietro e Ambrogio Lorenzetti completano il panorama artistico dei pittori senesi più rappresentativi in età gotica. Di essi non si hanno più informazioni dopo il 1348, per cui si è ipotizzato che la peste da cui Siena viene colpita in quell’anno, abbia causato la morte di entrambi i pittori.
Non abbiamo notizie certe in merito alla loro formazione, presumibilmente avvalorata da un periodo di frequentazione della bottega di Duccio di Buoninsegna e dalla conoscenza delle opere di Simone Martini e di Giovanni Pisano. I Lorenzetti apprendono, inoltre, le fondamentali innovazioni pittoriche di Giotto.
Questi molteplici stimoli vengono rielaborati in un linguaggio originale e autonomo, che pur restando nell’ambito della raffinata tradizione artistica senese inaugurata da Duccio, propone una più significativa apertura ai modi fiorentini.
Pietro, in particolare, subisce il fascino del linguaggio giottesco durante il suo soggiorno ad Assisi per la decorazione ad affresco del transetto sinistro della Chiesa Inferiore di San Francesco, con Storie della Croce.

In questa esperienza, l’artista dà prova della sua capacità di conferire una profondità credibile agli spazi, senza rinunciare alle eleganze lineari e cromatiche tipiche della pittura senese, vivificate da una più drammatica tensione espressiva ispirata a Giovanni Pisano.
Anche Ambrogio, definito dai suoi contemporanei come pittore colto e raffinato, mostra un gran interesse per la definizione degli spazi, prediligendo la cura dei particolari più minuti e l’attenzione alla caratterizzazione fisionomica dei personaggi.
Tra le sue opere spicca il celebre ciclo di affreschi realizzato per la Sala della Pace del Palazzo Pubblico di Siena, tra il 1337 e il 1339. Il titolo originario di questo importante lavoro era “La pace e la guerra”, poi sostituito nel XVIII secolo dal più descrittivo “Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo in città e in campagna”.
Si tratta di una complessa trama iconografica, che si apre a una dimensione politica e filosofica, con palesi riferimenti allo stato senese, protagonista all’epoca di un periodo di potere.
Le riflessioni pittoriche di Ambrogio sono rivolte alla sua città, ma al tempo stesso si riferiscono a una qualsiasi realtà territoriale, poiché è in base all’azione governativa che si determinano gli equilibri urbani e rurali di un luogo.

L’artista cede al suo consueto gusto per i dettagli, senza rinunciare a una sapiente regia intellettuale dell’opera, qui finalizzata a esiti ben precisi.
Personificazioni dotte di concetti ora concreti, ora astratti, descrizioni ben particolareggiate della vita cittadina, allegorie di Vizi e Virtù concorrono a un intento didascalico e morale rivolto a tutti i cittadini, offrendo loro la possibilità di scegliere tra il Bene e il Male attraverso la fruizione delle immagini.
In questo celebre ciclo, Ambrogio interpreta la saldezza dei valori civici di Siena, facendosi portavoce di un momento storico favorevole alla sua città con un linguaggio che, pur aderendo alla realtà, la esprime in modo lirico, come fosse una favola incantata.
Mariaelena Castellano
PER SAPERNE DI PIÙ …
LA PITTURA SU VETRO
In età gotica, un ruolo fondamentale nella decorazione architettonica spetta alle pittoresche vetrate colorate, che trovano posto nei rosoni e nelle grandi finestre ogivali delle chiese, animandole con vivaci immagini istoriate.
In realtà, la tecnica di realizzazione delle vetrate è molto antica, risale agli ultimi secoli dell’Impero Romano, ma trova piena applicazione e vasta risonanza nel periodo gotico, grazie all’ampia disponibilità delle superfici aperte.
L’arte vetraria riscuote gran successo soprattutto in Francia, giungendo ad essere ivi stimata come arte pittorica per eccellenza. Si diffonde, poi, anche al di fuori dei confini francesi, attirando l’interesse di pittori e artigiani dei paesi settentrionali, che realizzano opere di gran qualità. In Italia, il fenomeno resta più limitato, in quanto le superfici murarie non sono così leggere e traforate come nei paesi d’Oltralpe.
Il procedimento tecnico della vetrata, distinto in più fasi complesse e accurate, richiede la professionalità di una manodopera esperta in diversi ambiti, ragion per cui nei paesi del Settentrione europeo nascono botteghe artigianali specializzate, spesso frequentate anche dai pittori ideatori delle immagini.
Il primo stadio consiste nel tracciare il disegno su un supporto di legno, in seguito sostituito dal più maneggevole cartone.
In base alla bozza effettuata si preparano gli antelli, ossia i singoli pezzi di vetro, dalle forme e dai colori più adatti. L’impiego di più parti di vetro colorato si spiega anche per la presenza di vetrate sempre più estese e la mancata conoscenza di un sistema di lavorazione di un’unica lastra di grandi dimensioni. I singoli pezzi utilizzati vengono legati tra loro da cornici di listelli di piombo a forma di “H”, la cui malleabilità consente l’adattamento alle varie sagomature; quindi, si procede con la saldatura dei listelli tra loro, sempre tenendo conto del disegno di partenza. Questa intelaiatura, oltre a tener saldi i vetri, evidenzia i contorni creando suggestivi effetti cromatici.
Infine, la fase finale prevede l’inserimento della vetrata in un’armatura di ferro, pronta a essere collocata nella finestra o nel rosone.
Intorno alla metà del Duecento, questa tecnica raggiunge risultati più innovativi con la messa a punto della grisaille, consistente in una tinta di colore scuro ricavata dalla mescolanza di varie polveri di vetro e di ossidi con acqua, aceto e resine vegetali.
Sovrapponendo la grisaille ai vetri colorati, questi diventano opachi. Sullo strato ottenuto è quindi possibile graffire con uno strumento appuntito, per far così riemergere a tratti l’originaria colorazione lucida, in un singolare e ricercato contrasto luministico; con l’uso di un pennello è altresì possibile dipingere sul rivestimento opaco, in modo da realizzare eleganti effetti chiaroscurali, ma anche caratteristiche descrizioni di minuti dettagli.

Una volta effettuati questi interventi, occorre cuocere di nuovo i vetri per poter fissare la grisaille alla pasta vitrea, procedendo poi all’inserimento dei vetri decorati nelle legature di piombo e nell’armatura di ferro.
Verso gli inizi del Trecento, alla grisaille si aggiunge anche l’uso del cosiddetto “giallo d’argento”, un composto di acqua, ocra gialla, resine vegetali e nitrato d’argento macinato.
Il “giallo d’argento” viene steso sul vetro e amalgamato a esso mediante cottura ad alta temperatura. Ne derivano singolari colorazioni di una gamma cromatica che va dal giallo vivo all’arancio scuro.
Che sia lavorata a grisaille o a giallo d’argento, la pittura su vetro in età gotica vive una gran fioritura, caratterizzandosi per il suo sorprendente effetto decorativo, dove la trasparente policromia delle immagini sgretola la compattezza delle masse murarie, consentendo suggestivi effetti luministici e ponendosi come mirabile esempio dell’esuberante sfarzosità gotica.
L’ICONOGRAFIA DELLA MAESTA’
Nel Duecento e nel Trecento, nell’ambito dell’iconografia mariana, si afferma la tipologia della Vergine hodigitria, “colei che conduce”, ovvero la Madonna in maestà, assisa in trono, con in braccio Gesù Bambino, circondata in gloria da angeli e santi.
Inizialmente resta forte l’influenza stilistica bizantina, data la secolare tradizione di tavole destinate alla venerazione raffiguranti la Madre di Dio.
Tuttavia, con la diffusione della nuova sensibilità gotica e con la rinnovata esigenza di una maggiore propensione al vero, il tema della Maestà assume differenti soluzioni formali, continuando a godere di una grande considerazione artistica e religiosa.

Intorno alla metà del XIII secolo si sviluppa anche la tematica opposta della Madonna dell’Umiltà, dove la Vergine con il Bambino si trova per terra o tutt’al più adagiata su un cuscino. Si tratta di una tipologia iconografica diffusa dagli ordini religiosi del tempo, in accordo con il loro ideale di povertà e semplicità della Chiesa.
LA VIA FRANCIGENA
Al volgere del primo millennio, la via Francigena costituisce una delle principali arterie stradali destinate ai percorsi di fede.
Attraverso i valichi alpini, queste tratte consentono ai pellegrini europei di visitare la tomba dell’apostolo Pietro a Roma e per tale motivo sono conosciute anche come vie Romee. Alcuni percorsi, inoltre, si spingono fino alla Puglia e ai porti d’imbarco per la Terrasanta.

Si tratta di un complesso viario nato nel Medioevo per soddisfare le esigenze di viaggio dei pellegrini diretti nella città del Papa o a Gerusalemme. Pertanto, lungo il tragitto si sviluppa un significativo flusso commerciale e culturale, che assume vitale importanza per le comunicazioni del tempo.
IMPARIAMO I TERMINI
(*) PALA D’ALTARE: Tavola pittorica, più raramente scultorea, di iconografia sacra, spesso incorniciata da una complessa strutturazione architettonica; in genere presenta un formato rettangolare ed è posta sull’altare o appesa alla parete di fondo del presbiterio.